- CAPITOLO I
La notte d’agosto s’è svampata nel vino nero pece, scintilla di brace che scoppia saltando dai pezzi di carne cruda di capra sfrigolante sulla quercia ardente. I paesani hanno suonato la lira e i flauti bestiali squarciando il manto del buio steso come un corpo morto sui monti malati atrofizzati tutt’attorno ad Africo. Le donne ballano, sgusciando dal cerchio come serpi, attorno alle fiamme alte del fuoco attizzato da pampine ancora fresche della potatura degli ulivi, lasciando le loro impronte di piedi neri caprini, sventolando vesti sudice nell’aria calda.
La musica bestiale spezza i polpacci, le spalle, ossessiva e martellante accelera sempre più veloce.
Il vino nero ha riempito lo stomaco, trasmutano in ombre i contadini satiri deliranti in adorazione.
La chitarra battente ruvida e bestiale suonata da un corpo diabolico, nascosto nel fondo delle tenebre, cassa di risonanza di note arabe pizzicate, l’altra gran chitarra ossessa, dalla cassa liscia e barocca e tonda, fa lo stesso giro di accordi perverso da sempre, si affretta, si alleggerisce, frulla, si agita.
Gli sguardi di soppiatto, sopracciglia folte e nere, si mischiano e languidi si sciolgono con l’alcool, l’odore aspro della campagna e del fumo fresco, le ciocche di capelli, tostate dal sole secco di luglio, scosse nella danza.
«Cazzo faccio qua scattato sulla polvere tra i selvaggi» sospirò Uzzibì, in un attimo di malinconia raccapricciante, ruttando vino misto a capra selvatica.
C’aveva dato dentro il vecchio Uzzibì, poco più di vent’anni e biondo come un dio nordico: vino scuro scuro, secco e aspro, aveva attaccato le sue labbra pallide svedesi alla latta consumata del boccale ruvido, un sorso, un sorriso, un sorso e scendeva giù lento lungo la gola, un sorso per il viaggio, uno per la fatica degli ultimi mesi, un sorso e uno sguardo alle donne dalla pelle di bronzo, un sorso al fuoco, uno per tirar via il sapore dalla bocca del grasso impastato di capra, un sorso accanto al fuoco, un sorso ai suonatori, mentre intorno la gente vociava confusa con quella lingua rocciosa.
Umbertino Zanotti Bianco non aveva paura dei selvaggi a piedi nudi, né della notte che calava su quei monti scarni, abbandonati dal buon dio, e aveva fegato di bevitore torinese e lussuria coltivata nei migliori caffè borghesi parigini.
E allora un altro sorso di vino nero petrolio, Uzzibì, e la ragazza che aveva zampettato sulle rapide fughe dei satiri sonanti gli lanciò un fulmine di sguardo e «Come ti chiami?» gli chiese per spezzare quell’imbarazzo gonfiato. Quella quasi indispettita, s’asciugò il sudore sulla tempia con lo scialle grezzo che aveva legato ai fianchi, racchiusi in una veste blu che per poco non cascava a brandelli. «Mi chiamo Concetta Tripodi fu Francesco e vengo da Bianco, due giorni di cammino da quella parte», e indicò col braccio la direzione che avrebbe dovuto ripercorrere, si strinse nelle spalle, poi con la testa gli si fece vicina come una gatta all’ombra del grande fuoco cercandogli col naso i baffi.
Uzzibì aveva bevuto quella sera. Era arrivato su quel monte dopo tre giorni di cammino con i muli carichi e il sole atroce che gli spaccava in testa dei macigni roventi. Trangugiò ancora un sorso di vino pece, poi le offrì l’ultimo sorso, lei mandò giù. Il ragazzo abbozzò un sorriso sotto al baffo biondo bruciato dal sole, la donna allumò un’occhiata intensa per distinguere qualche ombra familiare al di là del fuoco, poi agguantò l’ospite dalla mano e lo portò sperduto in mezzo ad una radura della notte.
La donna pantera, occhi neri, era un mistero, gli si avvicinò seria fino a sentirne l’alito aspro di vino, lui le sfiorò la punta del naso, ascoltò la pelle liscia delle braccia scorrere sotto le sue dita, i calli delle mani, quell’odore selvaggio di cui trasudava la veste, i muscoli della schiena potenti, i fianchi snelli.
I due si stesero sull’erba ancora calda dal sole, lei gli fu sopra e si slacciò la veste annodata sul davanti, il suo sapore di pioggia estiva nei campi arsi le esplodeva dal seno, mentre nell’aria i grilli frinivano e le lucciole beccavano le dolci more di gelso.
La donna locomotiva sopra Uzzibì, impossessata dallo spirito del monte, respirava curva sulla sua clavicola dimenando i fianchi di lato e indietro. Alla fine schiuse la bocca mordendogli la spalla per soffocare rantoli d’amore, fu allora che Uzzibì esplose rapido come un branco di giovani merluzzi del baltico. I due stettero inermi uno sopra l’altro a calmare il respiro, godendo accaldati l’aria fresca della notte d’estate. La donna poi rinchiuse lo scrigno del suo cuore e tutti i suoi pensieri sotto il velo sottile della vestaccia. Sgusciò via salutandolo con un bacio.
Uzzi rimase solo con la notte incauta del bosco, s’arrotolò una sigaretta, poi si stese con le mani dietro la testa e gli occhi semichiusi verso i bagliori del fuoco lontano, pensava alla sua missione tra la perduta gente, ai caffè di Parigi e al profumo delle giovani ragazze in pelliccia e alle automobili e ai giornali e a sua madre salutata a Torino.
E pensò ad una spiaggia di ciottoli levigati a Creta e alle ombre fresche del palazzo in cui trascorse l’infanzia, lui bambino minotauro sulla battigia ardente e la madre era così bionda, così lontana e profumata, con lo scialle di seta sulle spalle soffiato dal vento.
E poi il viaggio, andare per mare sul ponte della nave russa -Ophelia, l’arrivo al porto di Reggio Calabria distrutta dal terremoto, un cumulo di macerie, odore rancido di cadaveri a marcire sotto al sole, e ancora il viaggio sempre più dentro quella terraccia malata, così schiantata dalla storia, immobile, con quella perduta gente dal grugno incattivito dagli eventi, la sua discesa nel fondo dell’abisso.
E ora, lì schienato sul fondo di quella radura d’erba calda distingueva di netto le stelle fisse appiccicate al cielo, le lucciole traballanti da lontano, il bagliore del fuoco, sempre più soffuso.
Anche la musica si fece meno densa e le risate rotte della gente si persero nella notte e lui si spense con le mani dietro la testa nel pieno del suo scuro abisso.
Un gelo differente si fece largo tra i pantaloni strisciando dritto sul fianco, lungo la schiena. Uzzibì schiuse gli occhi, la notte era circa alla fine, ma lui non lo sapeva. In quel buio cremoso, con le mani addormentate dietro la capoccia e le braccia inermi, come fosse un mutilato di guerra, schiuse appena gli occhi, per come il sonno glielo consentiva. Una silhouette subumana emergendo dall’ombra, accovacciata sul suo ventre, scuotendosi col capo ricurvo e col respiro greve, sembrava come un sogno di bambino. L’ombra arraffava su e giù, scuotendosi sul ventre del dormiente narcotizzato dal vino, dal sonno e dalla fatica dei giorni. Solo il lampeggiare di una lucciola che stava a passare lì nei pressi, scosse il cervello atrofizzato di Uzzibì che collegò quel corpo pesante sul suo ventre saltellante alla pressione avvertita sulle gambe e sulla sua verga. L’ombra subumana, arrancante e incurvita, lo stava cavalcando a ritmo lento, trattenendo pesanti sospiri , scuotendo ai lati il capo ricurvo a peso morto. Uzzibì raggelò, ma già il sangue delle sue braccia, delle mani, del busto era congelato. Non riusciva a muovere nessun arto, avrebbe voluto piombare di lato e con un braccio levarsi di torno quell’essere ignoto. Nulla di tutto ciò. L’entità goffa e pesante continuava a stantuffarlo in un silenzio imbarazzante. Uzzibì , ora completamente conscio, poteva sentire il gelo dell’ombra avvolgergli la verga, il sudore liquido colargli dalla fronte sulla tempia, odore nauseabondo nell’aria della notte densa, ora, nebbiosa e stagnante. Uzzibì inquieto e nervoso, nel pieno di una paralisi di tutti gli arti, tentava goffamente di contorcere i fianchi, immobili dal peso della bestia. L’ombra, a un tratto, smise di contorcere il capo a peso morto ai lati, lo raddrizzò e spalancando le fauci enormi rivelò una bocca illuminata da un bagliore rosso fluente dalla cavità putrida dell’esofago, il riverbero luminescente mostrava zanne corrose incrostate. Fu lì che il cuore di Uzzibì ritornò a pompare forte, che il sangue nei polsi riprese a fluire. E stava già per alzare le mani dalla testa, quando un uomo come un lampo si scaraventò sull’ombra con una mazza di ferro, assestando un colpo netto sul capo del mostro che lo sbalzò di soppianto dal ventre di Uzzibì dritto sulla polvere. L’ombra richiuse le fauci e nervosa si erse rapida in piedi, scivolando e prendendo la fuga nella notte. Uzzibì dallo sguardo smarrito, osservando alla debole luce della luna la sua verga ancora pulsante, immersa in un liquido amniotico grigio e filamentoso, fece un cenno di sorriso all’uomo che in piedi dritto a lui gli aveva salvato la vita… «Che cazzo stava succedendo qua?».
«Il folletto t’ha scelto», fece quello con aria a mezzo tra il divertito e il preoccupato. «È un demone che sta tra i monti, non credo faccia del male, ma non ne avevo mai visto neanche uno fino ad ora. Mia nonna mi avvisava da bambino, “Fai attenzione! Se arriva, tu scaccialo via”, credevo fosse una favoletta».
L’uomo gli porse una bottiglia di vino e Uzzibì tracannò con sazietà dallo spavento, «Che resti tra noi» sentenziò l’uomo serio, «La notte veglierò con un occhio di riguardo su di te».
.
Giancarlo Pitaro




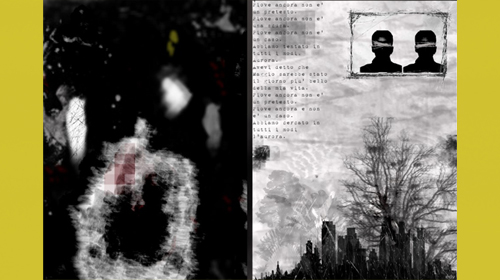



qualcosa veglia su di te ……
:O
uzzibi’ uno di noi !!!
Ti piacerebbe!!! :))
Adoroooo!!! Pitaro e’ sempre un esperienza potente! Un modo di scrivere che secondo me ti si appiccica nei meandri dell’ inconscio e poi non ti lascia piu’
Bravissimo sempre davvero
Ma chi sara’ questo Uzzibi’ ???
MI E’ VENUTA VOGLIA DI RILEGGERE ANCHE GLI ALTRI RACCONTI ,FORSE ANCHE MEGLIO DI QUESTO .
G.PITARO E’ IMMAGINIFICO CON UNO STILE ORIGINALISSIMO, SE LE STORIE RIMANGONO IMPRESSE C’E’ UN MOTIVO
🙂